

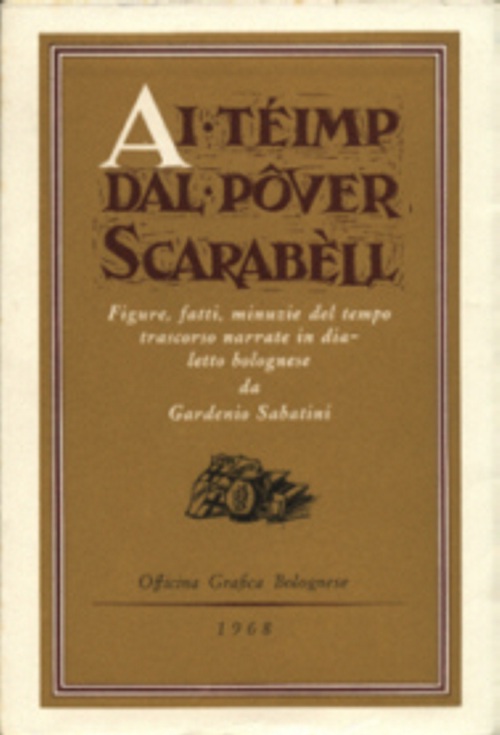

Mo qué ai véns un fât ch’l avanzé memorâbil par tant tänp. Finé la funziån, la câsa la fó purtè in spâla infén ala barléṅna ed prémma clâs, naigra e ôr, tirè da quâter cavâl nîgher con la quêrta, e al cucîr in custómm con la pirócca e al tricôren, ch’l avêva mandè la Cmóṅna; ed fianc i s miténn i amîg dal môrt, de drî la famajja, pó äl bandîr, äl curån e tótt chi èter.
Davanti l avrêva al curtéi, cómm s uṡèva alåura, al sagristàn con la sô palandrèna viôla burdè d ôr, e an inpôrta dîr cómm al nòster Scarabèl as sintéss urgugliåuṡ; ai parêva d èser un generèl in èlta montûra, ch’al fóss davànt al sô regimänt ch’al turnéss da una batâglia vénta. De drî a ló ai êra un ciarghén ch’al purtèva la cråuṡ, tra èter dû ch’i tgnêven na tôrza pr ån; pó i vgnêven i prît ch’i arénn dè l’ûltma benziån al cunfén dla paròchia e dåpp i srénn turnè ala cîṡa, mänter al môrt, con tótt chi sarafón de drî, al srê andè ala Zartåuṡa a fèr la tèra da pgnât.
Al curtéi al s avié żå par la stradléṅna in disaiṡa che da San Żvân in Månt la và in San Stêven; mo pròpi quèṡi ala fén ed sta stradléṅna, zêrt operèri i avêven fât un bûṡ in tèra da na pèrt, parché al s êra rått un tûb dal’âcua, siché la barléṅna la i pasèva apanna. Mo gnanc a fèrl apòsta, in mèż a claAi ténp dal pôver Scarabèl mèża strè, al s êra farmè un servitåur d un sgnåuri con tant ed giâca a ptón d ôr con la curåṅna, ch’al conduṡêva un can a fèr la sô âcua e anc quèl èter s’ai scapèva. L êra un cagnâz gròs che al sô padrån al l avêva purtè dal’Inghiltèra che chisà cus’al l avêva paghè; l êra, cum as dîṡ, un buldògg ch’l avêva nómm “Wellington”.
As sà cum i én i can: prémma ed dezîdres a fèrla, i pänsen zänt vôlt, fôrsi parché - esànd däl bîsti dimóndi inteligiänti - i vôlen che al sît in dóvv i la lâsen al séppa pròpi al sît giósst. Al fât l é che dal tänp di ténp tótt i can i nèṡen in tótt i cantón, pò s’ai pèr i in fan un puctén int un sît, un puctén int un èter, e vî d lóng infén ch’i n an finé. Siché dånca, cum ai ò détt, ste servitåur al conduṡêva Wellington a fèr i sû biṡóggn; quand sta gròsa bîstia, dåpp avair naṡè zänt cantón, as và a farmèr pròpi in mèż a cla mèża strè in dóvv ai avêva da pasèr al môrt. Al servitåur l êra inbarazè, an savêva cum as fèr; parché l avêva un bèl tirèr la cadäṅna, mo ste cagnâz, ch’al pṡèva fôrsi s-santa chíllo (e ch’al magnèva, gêva al servitåur, cómm trî cristiàn) ed môvres a n in avêva brîṡa vójja, anzi an s muvêva gnanc pr insónni. L avêva strichè äl ganb de drî avṡén a qualli davanti, e sänza pensèr tant ai problêma di èter al badèva såul a spénnżer con i vésser dla sô panza. E intànt al curtéi al vgnêva avanti; Scarabèl l êra bèle davanti al can. E al servitåur al badèva a dîr: “Andän, Wellington, ténla par st’ètra vôlta, lâsa pasèr al môrt”. E lo nå. “Andän Wellington, t an è brîṡa ciapè al mumänt giósst”. E ló ignénte.
Fenalmänt, un quèl al véns fòra, e al servitåur ai véns la speranza che al can al se spicéss. Invêzi, dåpp a tant sfôrz, l avanzé a metè...
Al servitåur al turné col bôni: “Và mò là, Wellington, tâja a mèż! Al rèst t al farè pò un’ètra vôlta”. E ló nå. “Wellington, t î na caråggna! T um fè fèr na figûra balåurda. S’al t vdéss al tô padrån al t darê däl bòt...” E ló gnénte; anzi al s ajustèva col ganb de drî par spénnżer méi.
L êra bèle dîṡ minûd bón, che l’illustre defunto, onore e vanto della nazione e della città, al stèva d asptèr pr andèr ala Zartåuṡa che un can di nobile razza l avéss fât i sû biṡóggn, quand ai suzdé l apucaléss...
Scarabèl, ch’al conduṡêva al curtéi, e as sintêva cómm al responsâbil dal bån åurden dla zerimògna, ai véns só la fótta; al lasé andèr un gran chèlz int al cûl al can, digandi:
“Mo ch’at ciâpa un azidänt! Cus’èt magnè, däl sôrbel?”
L an l avéss mâi fât! Al can al s infurié, al s instizé, al dé un stratån ala cadäṅna, ch’la scapé d in man al servitåur. Al s avinté adòs a Scarabèl, ch’al scramazlé par tèra, mo al fé a tänp a livères e a dèrsla a ganb mänter al can al s êra inzanplè int la sô cadäṅna. I ciarghén i scapénn vî: i prît i s arpiaténn däntr un purtån; quall ch’l êra in sêrpa ala barléṅna con la pirócca e al tricôren, vdand pr un mumänt lébbra la strè davanti ai cavâl, ai dé la målla, pinsànd che par mèl ch’la fóss andè, l êra fôrsi al mèl pió cén. Mo la strè l êra in pendänza, e la barléṅna la ciapé na spénta ch’i n la psêven farmèr pió inción. L’infilé ed lóng Piâza San Stêven, e vî d gran carîra l’atravarsé la zitè tra la maravajja ed tótt e fôrsi anc dal môrt ch’ai êra dänter.
I parént, i nobili rappresentanti, intànt, i êren avanzé ed stócc, tótt sparpajè a metè dla stradléṅna ed San Żvân in Månt, parché quî ch’i êren de drî i n savêven brîṡa la càuṡa ed cal putifêri; ad ògni môd, inción l avêva tant fiè da córrer drî al môrt, anc s’ai n avéss avó vójja.
Ed ecco che successe un fatto che rimase memorabile per tanto tempo. Finita la funzione, la cassa fu portata in spalla fino alla berlina di prima classe, di colore nero e oro, tirata da quattro cavalli neri con la gualdrappa e il cocchiere in costume con la parrucca e il tricorno, mandato dal Comune; di fianco si misero gli amici del morto, dietro la famiglia, poi le bandiere, le corone e tutti gli altri.
Davanti ad aprire il corteo, com’era l’usanza, c’era il sagrestano con la mantella viola ricamata d’oro, ed è inutile dire come il nostro Scarabelli si sentisse orgoglioso; gli pareva di essere un generale in alta uniforme davanti al reggimento dopo una battaglia vinta. Dietro di lui c’era un chierichetto che portava la croce, tra altri due che tenevano una torcia per uno; poi venivano i preti che avrebbero dato l’ultima benedizione al confine della parrocchia e sarebbero poi tornati in chiesa, mentre il morto, con tutti quegli ipocriti dietro, sarebbe andato alla Certosa per il riposo eterno.
Il corteo imboccò la stradina in discesa che da San Giovanni in Monte va in Via Santo Stefano, ma proprio quasi al termine della stradina degli operai avevano aperto un buco in terra da una parte, perché si era rotta una tubatura dell’acqua, così che la berlina passava a fatica. Neanche a farlo apposta, in mezzo a quella strada, si era fermato il servitore di un signore con tanto di giacca coi bottoni d’oro con la corona, che portava un cane a far pipì, e anche qualcos’altro in caso di necessità. Era un cagnone enorme che il padrone aveva portato dall’Inghilterra dopo averlo pagato chissà quanto; era, come si dice, un bull-dog, e si chiamava “Wellington”.
Si sa come sono i cani: prima di decidersi a farla, ci pensano cento volte, forse perché – essendo animali molto intelligenti – vogliono che il luogo in cui lasciano i loro bisogni sia proprio quello giusto. Il fatto è che dal tempo dei tempi tutti i cani fiutano dappertutto, poi se par loro opportuno ne fanno un po’ da una parte, un po’ da un’altra e così via fino a che non hanno terminato. E così, come ho detto, questo servitore portava Wellington a fare i suoi bisogni; quando questo imponente animale, dopo aver fiutato in cento angoli, si va a fermare proprio in mezzo alla strada in cui doveva passare il morto. Il servitore era imbarazzato e non sapeva come fare, perché aveva un bel tirare la catena, ma il cagnone, che pesava forse sessanta chili (e che mangiava, diceva il servitore, come tre esseri umani) di muoversi non ne aveva voglia, e anzi non si muoveva affatto. Aveva stretto le zampe posteriori vicino a quelle anteriori e, senza pensare tanto ai problemi altrui, era tutto occupato a contrarre le viscere. E intanto il corteo avanzava; Scarabelli era già davanti al cane. E il servitore diceva: “Andiamo, Wellington, tiella per la prossima volta, e lascia passare il morto”. E lui no. “Andiamo Wellington, non hai scelto il momento giusto”. E lui niente.
Finalmente, qualcosa uscì, e al servitore venne la speranza che il cane si sarebbe sbrigato. Invece, dopo tanto sforzo, rimase a metà...
Il servitore ci riprovò con le buone: “Ma dai Wellington, taglia a metà! Il resto lo farai un’altra volta”. E lui no. “Wellington, sei una carogna! Mi fai fare una figuraccia, se ti vedesse il tuo padrone te le darebbe...” E lui niente, anzi si aggiustava con le zampe posteriori per spingere meglio.
Erano già dieci minuti buoni che l’illustre defunto, onore e vanto della nazione e della città, stava ad aspettare di andare alla Certosa che un cane di nobile razza avesse fatto i bisogni, quando si scatenò l’apocalisse...
A Scarabelli, che guidava il corteo e si sentiva responsabile per l’ordinato svolgimento della cerimonia, saltò la mosca al naso; assestò un calcione nel sedere al cane, dicendo:
“Ma che ti venga un colpo! Cos’hai mangiato, delle sorbole?”.
Non l’avesse mai fatto! Il cane montò su tutte le furie e dette uno strattone alla catena, che sfuggì di mano al servitore. Si avventò contro Scarabelli, che piombò per terra ma fece in tempo ad alzarsi e a darsela a gambe perché il cane era inciampato nella catena. I chierichetti scapparono via, i preti si nascosero in un portone, il cocchiere con la parrucca e il tricorno, vedendo per un momento la strada libera davanti ai cavalli, dette il via, pensando che, per quanto fosse andata male, era forse il male minore. Ma la strada era in pendenza, e la berlina prese uno slancio che nessuno riusciva più a fermarla. S’infilò a tutta velocità in Piazza Santo Stefano, e di gran carriera attraversò la città per la meraviglia di tutti, e forse anche del defunto che c’era dentro.
I parenti, i nobili rappresentanti, nel frattempo, erano rimasti di stucco, tutti sparpagliati a metà della stradina di San Giovanni in Monte, perché quelli che seguivano non sapevano la causa di tutto quel putiferio; in ogni modo, nessuno aveva tanto fiato da correre dietro al defunto, anche se ne avesse avuto voglia.

